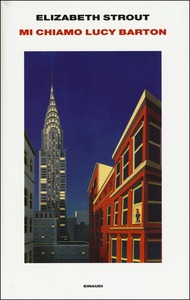
Elizabeth Strout è uno di quei nomi che mi è capitato di notare centinaia di volte in libreria e su molte pagine internet. Ho spesso snobbato chi genera tanto clamore. Poi, quasi senza volerlo, ho deciso di leggere uno dei suoi romanzi. Uno qualsiasi, mi sono detta. È una donna che scrive e, forse, vale la pena leggere qualcosa per crearsi almeno un’opinione. Ebbene, nonostante la quasi casualità e l’iniziale diffidenza, ho trovato Elizabeth Strout decisamente interessante. Mi è piaciuto molto il modo in cui la scrittrice americana ha tessuto la trama del suo “Mi chiamo Lucy Barton”, il modo in cui ha saputo annodare e i filamenti di tante minuscole vicende così da compattarle in una storia tanto normale, tanto umana e, nel contempo, tanto delicata e profonda. Non c’è scalpore, non c’è rigidità, né il girovagare assente di chi dice senza dire. Anzi. Elizabeth Strout si muove agilmente tra le parole, i ricordi e i sentimenti dei suoi personaggi e sa trasferirli sulla pagina con un’attenzione speciale, con la serenità e il talento di chi sa esattamente cosa vuole scrivere e come riuscire a farlo in maniera impeccabile.
Ad aprire il romanzo, parlandoci in prima persona, è una donna che ricorda un’esperienza vissuta negli anni ottanta quando, per un problema di salute, è costretta a rimanere in un ospedale di New York per nove settimane. “A casa avevo un marito e due figlie piccole; le bambine mi mancavano tremendamente e la mia ansia per loro era tale che temevo potesse influire sul mio stato di salute“. La donna è Lucy Barton. Sa che suo marito è molto occupato e odia gli ospedali per cui non verrà a trovarla spesso e sa anche che le sue bambine saranno separate da lei fino a quando non uscirà da quella stanza dalla quale, ogni sera, osserva il grattacielo Chrysler “con la sua scintillante geometria di luci“. Di lei si occupa per lo più un gentilissimo medico che Lucy ricorda con affetto a distanza di anni. Più o meno dopo tre settimane di degenza, Lucy nota la figura di sua madre ai piedi del letto. Non la vede da moltissimo tempo e le sembra diversa. La donna la saluta con un affettuoso “Ciao Bestiolina” e le spiega di aver preso, per la prima volta in vita sua, un aereo. “Che lei fosse lì, che mi chiamasse con quel vezzeggiativo che non usava da una vita, mi fece sentire dentro il tepore di un liquido caldo, come se tutta la mia tensione fosse stata un grumo solido e adesso non lo fosse più“.
Cinque giorni. Solo cinque giorni. È il tempo che madre e figlia trascorrono insieme in quell’ospedale. Inizialmente a dividerle sembra esserci una specie di strano imbarazzo. Non sanno cosa dirsi, non sanno come dirlo. Poi iniziano a parlare di cose piccole e banali: le figlie rimaste a casa con il papà, il fratello di Lucy che vive ancora coi genitori, le infermiere che si muovono lì attorno. Lucy si stanca in fretta e la madre inizia a raccontarle aneddoti di persone conosciute tanto tempo prima, quando anche Lucy viveva ad Amgash, in Illinois. “Parlava in un modo che non ricordavo, come se parole, sentimenti e osservazioni le si fossero accalcati dentro per anni e adesso le uscissero in un sussurro disinibito. Di quando in quando mi appisolavo e, al risveglio, la pregavo di parlare ancora“. Lucy desidera solo che sua madre non smetta di raccontare. Ha bisogno di quella voce, ha bisogno di recuperare nomi di persone a cui non pensava da tanto tempo, ha l’urgenza di ritrovarsi in sua madre e di sentirla vicina e presente. In Lucy si mescola una specie di raggiante nostalgia con il bisogno atavico di riconoscersi figlia amata e coccolata.
Alle vicende di paese che sua madre racconta, spiegando il destino di Kathie Nicely o della cugina Harriet o della graziosa Mississippi Mary, si aggiungono i ricordi di Lucy prima che si trasferisse a New York, prima che si sposasse e mettesse al mondo due figlie, prima di diventare una scrittrice e prima di distaccarsi da certi luoghi e certe persone. La storia si muove su piani temporali diversi e, da questo punto di vista, la Strout è stata bravissima ad incastrare con equilibrio ed accortezza ogni evento, ogni dettaglio, ogni riferimento. Infatti, nonostante il continuo spostarsi sulla linea del tempo, nonostante i continui salti dal passato al presente e dal presente al passato prossimo e dal passato prossimo al futuro, la narrazione scorre senza intoppi e senza mai farsi sfibrante. C’è comunque una certa leggerezza nel modo in cui Lucy Barton (e quindi Elizabeth Strout) ci parla della sua dolente e complicata infanzia e delle sue esperienze di crescita e di avvicinamento all’arte della scrittura. Ed è sempre affascinante trovare in un romanzo riferimenti diretti al mestiere di chi scrive, come delle minuscole fessure luminose che permettono di afferrare qualche segreto (ammesso che di segreto si tratti) su come si possa scrivere e farlo bene.
Edizione esaminata e brevi note
Elizabeth Strout è nata a Portland, nel Maine, nel 1956 e vive da molti anni a New York. Si è laureata in letteratura inglese nel 1977 presso il Bates College e in giurisprudenza presso la Syracuse University, ha poi insegnato al Manhattan Community College. I suoi primi racconti sono apparsi su diverse riveste americane. Nel 2009 ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa con la raccolta di racconti “Olive Kitteridge” grazie alla quale, in Italia, si è aggiudicata anche il Premio Bancarella (2010) e il Premio Mondello (2012). I libri della Strout pubblicati in Italia: “Amy e Isabelle” (Fazi, 2000); “Olive Kitteridge” (Fazi, 2009); “Resta con me” (Fazi, 2010); “I ragazzi Burgess” (Fazi, 2013); “Mi chiamo Lucy Barton” (Einaudi, 2016); “Tutto è possibile” (Einaudi, 2017).
Elizabeth Strout, “Mi chiamo Lucy Barton“, Einaudi, Torino, 2016. Traduzione di Susanna Basso. Titolo originale “My Name Is Lucy Barton”.
Pagine Internet su Elizabeth Strout: Sito ufficiale / Wikipedia





Follow Us