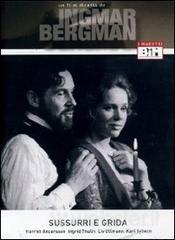
Su uno sfondo rosso, senza musica d’accompagnamento, cominciano a comparire i titoli di testa; nel silenzio, solo un lieve rintocco, davvero impercettibile, sembra echeggiare – è un orologio ornamentale, quasi vivisezionato da Bergman, che ne insegue ogni più piccolo dettaglio. Passeranno circa sette minuti, dai titoli di testa, prima che la voce faccia il suo ingresso nella pellicola. In questi sette minuti sospesi nel tempo c’è tanto del cinema del maestro svedese, c’è soprattutto un’idea estetica non vincolata dal rumore, dal suono, dalle parole che spesso distraggono dall’interiorizzazione delle immagini, dei luoghi, dei volti. Ci sono l’angoscia, il dolore e il dubbio. Il primo volto che incontriamo è quello di una donna, Agnese, adagiata sul letto e consumata dalla sofferenza fisica. È un dramma inquieto e inquietante quello che, il 21 dicembre 1972, esce in anteprima mondiale a New York, arrivando in patria solo tre mesi dopo. L’incipit che v’ho raccontato è quello di Sussurri e grida, una delle 6-7 opere universalmente note e celebrate di Ingmar Bergman, capolavoro assoluto della cinematografia d’ogni tempo, vero e proprio passaggio obbligato per gli appassionati del regista scandinavo e, più in generale, per gli amanti della settima arte. Prima di addentrarci nei motivi per i quali questa pellicola è un irrinunciabile approdo per chi ama il cinema (e l’arte in genere), tracciamone brevemente gli snodi essenziali.
È la storia di quattro figure femminili: tre sorelle, di cui una malata terminale di cancro, più una domestica. Le donne vivono in una villa alla periferia di Stoccolma, immerse nel gelo e nel silenzio, in attesa della morte della sorella, Agnese, quasi trasfigurata dal dolore fisico. Nelle stanze della villa convivono nevrosi e sentimenti: odio per la vita, indifferenza, incomunicabilità, dolore, amore – forse ingenuo, comunque puro. Bergman indaga, tra passato e presente, l’origine del male dell’anima di due delle tre sorelle, solitamente imperscrutabile, contrapponendolo a quello fisico della materia, straziante alla vista. Agnese è il simbolo del dolore fisico, della materia caduca che si consuma e che diventa, nell’idea salvifica del messaggio cristiano, involucro di sofferenza e di espiazione del peccato connaturato nell’essere umano. Agnese come il Cristo, azzardò qualcuno dopo aver visto il film, denudata alla vista dello spettatore pare trattenere la sofferenza del mondo sul corpo esile e consumato dalla malattia. Espiazione – Bergman resta nell’eterno dubbio, mai venuto meno nonostante un’indagine lunga oltre quaranta pellicole, su cosa ci sia oltre la morte. A seconda degli stati d’animo che lo hanno attraversato nel tempo di una vita vissuta senza risparmio creativo ed affettivo (nato nel 1918, e cresciuto sotto la severa educazione di un padre pastore protestante, è deceduto appena due mesi e mezzo or sono, avendo avuto cinque mogli e numerose amanti. Bergman era anche un uomo emotivo, somatizzava molto e soffriva di colite), ci ha regalato opere a volte possibiliste e a volte meno sulla speranza di raggiungere la pace e l’armonia nella vita altra, dopo aver inevitabilmente espiato in questa. Quando egli entra nell’analisi del circolo vita-morte va ad incontrare, immancabilmente, il tema miscredenza-fede. In Sussurri e grida vince lo scetticismo; non solo, vince una consapevolezza colma d’inquietudine, consapevole che il dolore patito in terra, pur non portando necessariamente al nulla e al vuoto eterno, può imprigionare le anime che hanno cercato amore, illudendosi di trovarlo. Andando incontro, al contrario, ad atroci sofferenze. È sempre il caso di Agnese, convinta fino alla morte dell’amore delle sorelle nei suoi confronti, invece colme d’odio o indifferenza per una vita agiata ma futile e fasulla. E qui Bergman costruisce una delle scene più forti, tragiche e impietose della sua lunga carriera cinematografica, facendo risvegliare (tra l’onirico e il reale: la dimensione non è ben definita) l’anima della sorella appena defunta, convinta in vita d’essere amata, ora lucidamente consapevole del vuoto empatico fraterno, una volta creduto amore. È come se Agnese, conclusa la sofferenza fisica, torni dall’oltretomba per espiare nuovamente, percependo il non amore restituito dalle sorelle. Sono sequenze agghiaccianti, in cui Karin (la sorella fredda) e Maria (quella superficiale) sono immobilizzate dal loro demone. L’unica che porterà conforto all’anima della sorella morta è Anna, la badante che si occupava amorevolmente di lei per sublimare il dolore per una figlia perduta in tenera età.

Bergman connota in maniera ineccepibile le quattro figure femminili, indaga la loro psiche e restituisce i loro fardelli emotivi attraverso immagini altamente suggestive. E qui, oltre all’inconfondibile autorialità del maestro svedese, c’è da registrare l’efficacia della fotografia di Nykvist, di forte impatto emotivo, claustrofobica e ossessiva almeno quanto le scenografie di Marik Vos, in cui vince un rosso sangue persistente, affatto dissimile da quello che, successivamente, ispirò Dario Argento (Profondo Rosso). Le scenografie e la fotografia contribuiscono, insieme al sapiente tocco bergmaniano, alla percezione d’un’atmosfera allucinatoria continua, nella quale presente e passato si fondono e si confondono con l’onirico e il reale, ricordando dinamiche presenti in un altro capolavoro del regista scandinavo: Persona. Con Persona ci sono vicinanze evidenti, non solo nelle atmosfere proposte, ma anche e soprattutto nella scelta d’indagare i meandri dell’inconscio femminile. Impresa ardua da sempre, che a Bergman, nella fattispecie ma non solo, riesce con una naturalezza disarmante. Probabilmente, il cambiare spesso la compagna di viaggio nella vita reale non era solo un vezzo d’artista o un sintomo di noia, vista la fama ottenuta, ma un’intima necessità che lo aiutava a trasportare la quotidianità nell’arte. Arte e vita, nell’opera del maestro svedese come in quella di ogni grande artista, vissero sempre in uno stato simbiotico. In uno dei momenti più intensi della pellicola, quando Maria cerca empatia e chiarimento con Karin, Bergman e Nykvist fotografano ravvicinati i volti della Ullmann e della Thulin, immortalandoli in quadro che ricorda da vicino una delle iconografie del cinema bergmaniano per eccellenza: i volti altrettanto ravvicinati, in bianco e nero, di Liv Ullmann e Bibi Andersson, pronti a sovrapporsi nella successiva, memorabile sequenza (parliamo sempre di Persona). C’è un che di erotico, di saffico e per alcuni di morboso in questi avvicinamenti proposti dal regista, al contrario funzionali ad esprimere la complessità di un mondo, quello femminile, sovente imperscrutabile. Le figure maschili, diversamente, sono marginali ma simboliche, tutte negative o, nel migliore dei casi, ambigue (vedere il volto del pastore durante le parole di congedo alla sorella defunta, o il comportamento del medico).

Morte, vita, femminilità, incomunicabilità, sofferenza, aridità, ricerca d’empatia, mistero della fede e indagine dell’oltre. Sussurri e grida, dramma da camera che riunisce le tematiche centrali del cinema bergmaniano, è simile per ambientazione a Sinfonia d’autunno (tutto in interno e tutto al femminile), ma affine, per assonanza, a due “opere del dubbio” altrettanto inquiete: Luci d’inverno (un pastore che ha perso la fede) e Come in uno specchio (la follia trasforma Dio in un ragno), senza dimenticare Persona, di cui s’èra prima accennato. Nell’indagine di Bergman tutto, magicamente, considerando la portata dei temi proposti, si incastra alla perfezione, restituendo sempre, attraverso l’epilogo, il dubbio e il vuoto esistenziale come unici protagonisti rimasti sulla ribalta. Il finale della pellicola è lontano dalla consolazione ed amplifica, con una punta di lirismo che non lede il gelo, al contrario rafforzando la sensazione d’angoscia che ci ha assalito fin dai titoli di testa, il sostanziale pessimismo bergmaniano sulla capacità d’autoanalisi dell’uomo del Novecento: egoista e perso nelle sue crisi esistenziali, intrappolato nel buio dell’anima, vinto dal nichilismo passivo, ammalato nello spirito più che nel corpo. Si legge sul diario di Agnese: “sento di esser grata alla vita che mi ha dato tanto”. Cui Bergman fa seguire una didascalia biblica, una frase del profeta Geremia: “Quando le grida e i sospiri saranno passati”. Osservate la consequenzialità proposta dal regista, la vita restituisce quando si è dato in grida e sospiri, che poi è la stessa immaginata da chi aspira all’Eden cristiano: quando finisce la sofferenza (grida e sospiri) la vita mi darà tanto (gioia). Ed è questo l’inganno cui va incontro Agnese, credutasi felice in vita perché intimamente consapevole di espiare.

Dunque vi sarà chiaro il titolo, e il riferimento da cui ha attinto: Bergman dissemina la pellicola di sussurri, coprendo con l’amata musica classica (qui Chopin e Back) il dialogo chiarificatore tra Maria e Karin, riservandosi le grida per momenti strazianti, come quello in cui ci mostra impietoso la maschera di dolore di Agnese, soffocata dalla sofferenza. Si è decisamente ai limiti della sopportazione visiva, ve lo assicuro. Tra i sussurri e le grida sono notevoli le sequenze degli stacchi tra una situazione e l’altra (ancora una volta Bergman, costruendo il suo dramma da camera, ci regala una pellicola d’impostazione teatrale), nei quali sullo sfondo rosso sfumano i volti delle protagoniste, per riapparire, a volte per pochi ed emblematici secondi, costantemente angosciati e sussurranti parole nascoste dalla musica, per poi sfumare nuovamente in una dimensione a cavallo tra il sogno, il presente e il passato. Un’ ultima sequenza non si può tralasciare, quella in cui Karin sceglie di tagliarsi con un vetro all’altezza del bassoventre, spargendosi il sangue sul volto di fronte al marito: è una scena agghiacciante, in cui la Thulin sembra addirittura masturbarsi col pezzo di vetro.
Magnifiche le attrici, davvero affiatate, e menzione per Harriet Andersson, di una credibilità impressionante nel ruolo della malata terminale. Il maestro svedese, come di consueto, valorizza al massimo le sue attrici le quali, ottimamente dirette, non possono che dar lustro a un’opera già di per sé rimarchevole dal punto di vista tecnico e narrativo. Sussurri e grida pertanto rappresenta, unitamente a Fanny e Alexander, Il settimo sigillo, Persona e Il posto delle fragole, il meglio del meglio dell’opera bergmaniana. È tra i capolavori assoluti della settima arte ma non è un film per tutti, come avrete capito. Se amate Bergman e amate il grande cinema, è comunque il film per voi.
Curiosità: Sussurri e grida ottenne numerosi riconoscimenti internazionali, tra i quali Oscar 1973 per la migliore fotografia, David di Donatello 1974 a Bergman per miglior regista straniero e David speciale alla Andersson, la Thulin, la Ullmann e la Sylwan. Gran premio della commissione superiore tecnica al Festival di Cannes 1973. Wooody Allen omaggiò Sussurri e grida con Interiors (1978), pellicola che evoca un dramma simile a quello in questione, nella quale il regista newyorchese dichiara senza mezzi termini il suo amore per l’opera del maestro svedese.
Federico Magi, ottobre2007.
Edizione esaminata e brevi note





Follow Us