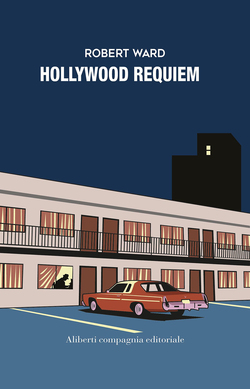
“Eravamo seduti tutti insieme, ci guardavamo ma facevamo finta di niente. Masticavamo gomma, bevevamo caffè, andavamo al cesso, pisciavamo, dormivamo. Restavamo seduti su quelle panche a fumare sigarette che non avevamo voglia di fumare. Ci guardavamo e quello che vedevamo non ci piaceva. Guardavamo gli oggetti sui banchi e le rastrelliere: patatine, riviste, noccioline, best seller, gomma da masticare, pasticche al fluoro, pasticche di liquerizia, fischietti.” (Charles Bukowski, Factotum, pag. 91, Guanda, 1996)
Stavo tornando dal lavoro con “Hollywood Requiem” nello zaino. Me l’ero portato dietro perché avevo una mezza intenzione di cominciare a leggerlo quel pomeriggio. Magari su una panchina vista lago. O nel bosco. Ma la mattinata lavorativa era girata così storta che di stare al lago, sotto il sole, insieme a ragazzini urlanti, passeggini, cani, madri annoiate non ne ne avevo la minima voglia. Quando l’avevo acquistato non sapevo nemmeno di cosa parlasse “Hollywood Requiem”. Semplicemente mi era fidato del talento di Ward e della scia dolorosa che aveva lasciato dentro di me “Io sono Red Baker” (Barney Edizioni, sempre tradotto da Manuppelli). L’avevo comprato in una delle solite librerie del cazzo e me l’ero messo nello zaino. Poi però niente. L’avevo lasciato lì per giorni. Dopo il lavoro avevo sete, tanta sete. E così mi ero fermato in un bar vicino casa per bermi una birra. Uno di quei bar destinati a scomparire. Dove ci stazionano gli alcolizzati già alle sei del mattino per la prima birra della giornata, gli anziani per il bianchino che dura tre ore davanti allo schermo della televisione o durante una partita di briscola, scopa. Luoghi di incontro, perdizione, sollievo. Lontani anni luce da tendenze di ogni genere. Mi ero seduto al bancone con ancora le impronte di unto della sera prima e avevo ordinato una birra piccola. La barista mi avevo servito sorridendo perché avevo capito il suo dialetto e non ero di certo uno di quei clienti occasionali che storcono il naso se non trovano happy hour, tramezzini, paste riscaldate, quadri di artisti contemporanei alle pareti, arredamento Ikea. Solo una birra con due olive, una patatina. In attesa della mia ragazza. Al mio fianco stava una tizia di trenta che ne dimostrava cinquanta di anni che prese a raccontarmi che mi aveva visto lavorare al cinema. Che andare al cinema costava troppo. Che dovevamo abbassare i prezzi. Le avevo sorriso. Era venuta al cinema con la figlia al seguito. Un sabato mattina. Impossibile dimenticarla visto che era bella sbronza e molesta. La bambina invece era gentile, sorridente. Simpatica. La donna mi aveva lasciato la mancia. E così, a quel bancone le avevo offerto il suo giro per ringraziarla. Non si era presa troppa confidenza e questo mi era piaciuto. Dietro, di lato, parlavano di immigrati, della nuova stagione del Lugano, fallimenti totali, divorzi, puttane, gonorrea, di affitti troppo alti, del persico e delle alborelle che arrivano tutte dall’Albania e poi tutta una serie di discorsi quasi sussurrati che lo si capisce subito che ruotano attorno a droga, truffe, ricettazione, traffichini, debiti, scommesse. Le finestre erano oscurate da tendine che non venivano mai lavate. Due cani che dormivano per terra. Un anziano che viveva nel mio stesso palazzo mi offrì un’altra birra. La tizia sorrideva e si grattava le braccia in astinenza. Il vecchio viveva attaccato alla bombola dell’ossigeno, un figlio morto per overdose, quarant’anni a fare il muratore. Si moriva di caldo nel bar. Ero uscito. Nello stesso palazzo una pizzeria d’asporto e un negozio sudamericano davanti a cui sostavano uomini coi muscoli gonfi e donne che lasciavano scoperto quanti più centimetri potevano del proprio corpo. Nasi gonfi di coca. Tutti con in mano una Corona. Finita la birra ero tornato a casa, un arrivederci alla donna e avevo cominciato a leggere questi quattro racconti (due dei quali, “Ispirazione” e “Billy s’innamora” in anteprima mondiale) magistralmente tradotti da Nicola Manuppelli (peccato per qualche refuso) uscendone sconvolto. Dentro ci ho trovato gran parte di quel mondo che avevo lasciato in quel bar. E non solo. Robert Ward ha quello stile che ti prende allo stomaco, ti mette ko come quando bevi troppo, ma soprattutto bevi troppo di fretta o continuativamente partendo molto presto la mattina. Da pugile che ti lavora ai fianchi, danza, balla e ti distrugge. Questi quattro racconti non fanno sconti a nessuno. Un po’ come quelle persone che vedevo al bar o che ho conosciuto durante la mia vita. Sono uno di quegli stronzi che se n’è andato dalla provincia per finire a vivere nelle città, fingendo di conoscere il mondo, di aver chissà come cambiato vita ma poi alla fine mi basta ritornare nel mio paese per capire che sono sempre al punto di partenza come succede a Thomas Weeks il protagonista di “Una specie di mostro”: sei ancora lì a sentirti dire che visto che sei a Lugano, Los Angeles, Milano stai facendo la bella vita, perché chissà cos’hanno sentito e intanto nessuno sa la vita di merda che stai facendo e sono sempre lì a puntarti il dito contro, sei sempre il solito ricchione di sempre, il bambinetto del cazzo che le prendeva e magari ci si mettono pure i parenti a guardarti con le loro facce da cazzo, con le loro vite da stronzi, da mostri. Ecco, quel personaggio lì è tremendo, un bastardo, lui e il suo amico di un tempo vivono al limite, uccidono, saldano i conti, se ne fregano e vanno avanti. Perché la vita va così, rimane sempre una brutta bestia feroce. Ne stendi uno a terra, ne fai secco un altro, lo riempi di botte, lo lasci per strada a piangere, guaire, morire e andrai comunque avanti perché c’è un’altra fica da scopare, da riempire col tuo cazzo gonfio, c’è un altro drink da bere, ci sono altri soldi da intascare. Però la merda ti insegue, mica ti lascia tranquillo. Col cazzo che succede. Ne ho vista di gente che da vent’anni sta seduta al solito bancone a bere a raccontare la solita storia di quel bastardo o di quella troia che li hanno lasciati o di quei soldi che non gli sono mai stati o di quella volta che ha perso il lavoro e non ne ha più trovato uno. Un incubo che dura tutta la vita. Non ti abbandona mai. Ti brucia da dentro. Ma quel viso, quel corpo lo vorresti ancora accanto a te. Anche se cadavere. Un corpo da abbracciare. Da scopare. Un incubo che si dilata come una galassia con il suo bel seguito di condanne, sensi di colpa, cagate varie, reati, disoccupazione, sfratti. Ma quel viso, quella voce, quelle labbra, quei muscoli, quell’abbraccio sono ancora tutto per te. Diventano dei fantasmi come accade nel racconto forse più devastante, “Chimica”, con quel Roger Deakens che brucerà la sua vita rincorrendo una donna, abbracciandone il fantasma, dopo essere stato fregato, truffato da due stronzi che si raccattano sempre nei bar, dopo essersi seppellito sotto un’autostrada di cocaina. Una sniffata dietro l’altra. Il naso ti sanguina. Ti sanguina tutto. Il cuore. Il cazzo. Lo stomaco. Il buco del culo. Il cervello. Stacchi questa donna dalla sua impiccagione. Ti ritrovi solo e meno solo. La solitudine che è pazzia ma non c’è migliore pazzia di quella che ci fa sentire meno soli nell’orrore dell’esistenza quotidiana. E sopra queste sventure magari ti viene voglia pure di scriverci, di farci i soldi, di fregarli quelli di cui ti senti magari simile ma simile non lo sei. Ti prendi le loro vite, le metti su carte, le trasformi in sceneggiature per film, serial. Fai successo, torni sulla cresta dell’onda, te ne freghi e quando il conto ti viene messo sul tavolo la sfanghi come nel primo racconto “Ispirazione”. Ecco che Ward ti butta al tappeto, perché si ricorda, sa, che la vita è davvero crudele, infame, vigliacca e che quasi sempre non c’è giustizia e non ci sarà mai. Qualcuno pensa che dopo la morte, lassù, da qualche parte in cielo i cattivi verranno puniti e i buoni andranno in paradiso ma per chi non ci crede, la verità è che si può finire al cimitero o in completa rovina senza che giustizia venga fatta. Senza che ci sia possibilità di riscatto. A un certo punto anche la speranza fa a farsi fottere. E intorno a te c’è gente che va avanti indisturbata mettendo i piedi in testa a destra e a manca, fregandosene se qualcuno soffre, se qualcuno si rovina la vita visto che a lui gira tutto per il verso giusto. Mica gli succede qualcosa a lui. E tu invece un cazzo. Neanche un numero sulla ruota della Fortuna. Niente. Come a Billy, in “Billy s’innamora”, lo stuntman che s’innamora perdutamente di una donna che pensa solo a prendersi gioco di lui perché anche l’amore è una brutta stronza che ti porta dritto al cimitero e mentre tu stai dormendo lei continua a ridere di te, a bersi il suo bel Martini, sdraiata comoda nella sua villa piazzata a picco sull’oceano o da qualche altra parte, Dio solo sa dove, di sicuro in qualche bel paradiso, dove tu, io, poveri stronzi come siamo non finiremo mai.
Edizione esaminata e brevi note
Robert Ward, Hollywood Requiem, traduzione di Nicola Manuppelli, Aliberti Compagnia Editoriale, 2016
Robert Ward è nato a Baltimora, attualmente vive a Los Angeles. Il primo romanzo, Shedding Skin, pubblicato nel 1972, ha vinto il “National Endowment for Arts”. Ha fatto parte della corrente del New Journalism, guadagnandosi la stima di autori come Tom Wolfe. Dopo la pubblicazione del quarto romanzo, Red Baker, nel 1985, ha cominciato a scrivere per la televisione. È autore e produttore di serie come Hill Street Blues e Miami Vice.
Recensione comparsa precedentemente sul blog wrongand.blogspot.it
Andrea C. luglio 2016





Follow Us